Con il gesto clamoroso, anche se storicamente poco appariscente, della purificazione del tempio (vangelo), Gesù mette in discussione l'istituzione più sacra della tradizione giudaica. Soprattutto è posto sotto accusa il modo comune di interpretare il rapporto con Dio. Il fatto che Dio abitasse nel tempio conduceva Israele alla presunzione di possedere Dio in modo definitivo, anche se la vita quotidiana non si lasciava trasfigurare dal rapporto unico e singolare che Dio aveva stabilito con il suo popolo. I profeti avevano più volte denunciato a chiare lettere l'illusoria sicurezza data dal formalismo religioso (cf Is 1,1ss; Ger 7,1-15; Mic 3,12) per riportare il culto ad integrarsi con la vita. Gesù si colloca in questa linea quando dichiara in modo perentorio la fine dell'istituzione templare, segno di un modo inadeguato di vivere il rapporto con Dio. Il gesto compiuto da Gesù è chiaramente provocatorio e scatena l'opposizione dei Giudei. Per giustificare la sua azione Gesù offre un segno: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Il tempio cui Gesù intende alludere è il suo corpo che sarà distrutto dalla morte, ma riedificato nella risurrezione. Santuario della divina presenza, e vero luogo dell'incontro con Dio è la persona di Gesù. Con la sua vita egli indica quale sia il vero culto che il Padre attende dal suo popolo (cf Gv 4,23-24): fare la volontà di Dio, aderire alla sua Parola, vivere la carità e la giustizia. Non è tanto allora il luogo sacro o il numero dei sacrifici che realizzano la comunione con Dio, quanto soprattutto quei segni ancora più espressivi di una profonda e genuina adesione interiore: l'offerta di sé, della propria obbedienza e volontà di conversione.
La vita cristiana non consiste in una serie di pratiche che possano giustificare o tranquillizzare la nostra «buona coscienza»: messa domenicale, formule frettolose e meccaniche, devozione a qualche santo «parafulmine» contro i guai della vita. «E' ben misera giustizia o bontà quella che si misura a termini di legge» (Seneca). Per entrare in comunione con Dio è chiamata in causa la vita con tutte le sue scelte quotidiane, piccole o grandi che siano. Il decalogo che Dio offre al suo popolo (prima lettura) non intende fondare un rapporto legalistico, né imporre un giogo; esso indica piuttosto le condizioni attraverso le quali è possibile vivere l'alleanza, quel vincolo unico e irripetibile con il quale Dio si è legato al suo popolo. La parola che la Chiesa è chiamata ad annunciare come dono di vita è la parola della croce (seconda lettura), segno supremo dell'amore di Dio. Ma questo messaggio sconcerta chi, in una apparente religiosità, pretende che Dio si adegui ai propri schemi. La vita cristiana non può aggirare o addomesticare la croce.
Con il gesto clamoroso, anche se storicamente poco appariscente, della purificazione del tempio (vangelo), Gesù mette in discussione l'istituzione più sacra della tradizione giudaica. Soprattutto è posto sotto accusa il modo comune di interpretare il rapporto con Dio. Il fatto che Dio abitasse nel tempio conduceva Israele alla presunzione di possedere Dio in modo definitivo, anche se la vita quotidiana non si lasciava trasfigurare dal rapporto unico e singolare che Dio aveva stabilito con il suo popolo. I profeti avevano più volte denunciato a chiare lettere l'illusoria sicurezza data dal formalismo religioso (cf Is 1,1ss; Ger 7,1-15; Mic 3,12) per riportare il culto ad integrarsi con la vita. Gesù si colloca in questa linea quando dichiara in modo perentorio la fine dell'istituzione templare, segno di un modo inadeguato di vivere il rapporto con Dio. Il gesto compiuto da Gesù è chiaramente provocatorio e scatena l'opposizione dei Giudei. Per giustificare la sua azione Gesù offre un segno: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Il tempio cui Gesù intende alludere è il suo corpo che sarà distrutto dalla morte, ma riedificato nella risurrezione. Santuario della divina presenza, e vero luogo dell'incontro con Dio è la persona di Gesù. Con la sua vita egli indica quale sia il vero culto che il Padre attende dal suo popolo (cf Gv 4,23-24): fare la volontà di Dio, aderire alla sua Parola, vivere la carità e la giustizia. Non è tanto allora il luogo sacro o il numero dei sacrifici che realizzano la comunione con Dio, quanto soprattutto quei segni ancora più espressivi di una profonda e genuina adesione interiore: l'offerta di sé, della propria obbedienza e volontà di conversione.
La vita cristiana non consiste in una serie di pratiche che possano giustificare o tranquillizzare la nostra «buona coscienza»: messa domenicale, formule frettolose e meccaniche, devozione a qualche santo «parafulmine» contro i guai della vita. «E' ben misera giustizia o bontà quella che si misura a termini di legge» (Seneca). Per entrare in comunione con Dio è chiamata in causa la vita con tutte le sue scelte quotidiane, piccole o grandi che siano. Il decalogo che Dio offre al suo popolo (prima lettura) non intende fondare un rapporto legalistico, né imporre un giogo; esso indica piuttosto le condizioni attraverso le quali è possibile vivere l'alleanza, quel vincolo unico e irripetibile con il quale Dio si è legato al suo popolo. La parola che la Chiesa è chiamata ad annunciare come dono di vita è la parola della croce (seconda lettura), segno supremo dell'amore di Dio. Ma questo messaggio sconcerta chi, in una apparente religiosità, pretende che Dio si adegui ai propri schemi. La vita cristiana non può aggirare o addomesticare la croce.

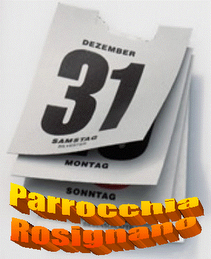
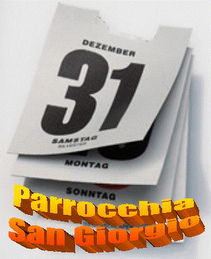





0 commenti:
Posta un commento